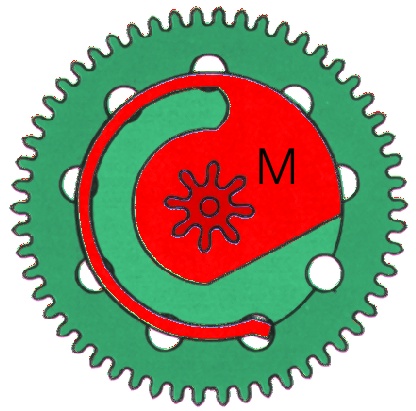|
Successivamente anche Breguet si
occupò ( e non poteva essere diversamente) di orologi automatici. Egli
era a conoscenza dell’orologio di Perrelet, ma utilizzò un sistema
diverso per far caricare i suoi orologi. Applicò infatti una specie di
“martello” che meglio sfruttava il movimento sussultorio dell’orologio
quando questo era messo nel panciotto del vestito.

|
|
Da qui in poi però ci fu una specie di oblio e nessuno
o quasi propose più orologi con carica automatica, fino a che, anche con
l’avvento degli orologi da polso, non arrivò un certo Harwood, agli
inizi degli anni ’20, al quale si attribuisce l’invenzione del primo
orologio automatico da polso, brevetto che registrò in Svizzera nel
1924.
Una dettagliata esposizione della storia di
Harwood e dl suo orologio è qui:
Il primo orologio automatico da polso
La figura sotto è uno schizzo del
sistema di carica dell'orologio automatico di Harwood, così come appare
quando si toglie il fondo della cassa. Il supporto della massa
oscillante A è imperniato al centro del movimento. Fissata a frizione ad
A c'è una platina F1 con un cricco sul suo lato inferiore. Questo cricco
ingrana sui denti della ruota W, che è la prima ruota del treno degli
ingranaggi di carica e svolge il doppio compito di ruota cricco e ruota
di trasmissione. La massa oscillante è provvista di un respingente a
molla ad ogni estremità. Due fermi limitano il suo movimento ad un arco
di circa 60°. Essa carica in una sola direzione e il movimento
effettuato nel senso della freccia è trasmesso, attraverso una frizione,
alla ruota W e da questa, attraverso due gruppi ruota-pignone P1 e P2,
alla ruota di carica del bariletto

La platina fissata a frizione F1
normalmente si muove assieme alla massa oscillante ed è tenuta per mezzo
di una molla regolabile F, la quale assicura che la platina ruoti
assieme alla massa oscillante finché la molla di carica è quasi
completamente carica (meno ¼ o mezzo giro). Harwood è convinto che il
normale sistema svizzero della molla che slitta all'interno del
bariletto quando è del tutto avvolta sia un errore. Egli sostiene che
può essere evitata una gran parte dell'usura del sistema di carica se la
frizione sul treno di ingranaggi è posta dal lato della massa
oscillante.
Anche in questo caso però, l’orologio
non ebbe un grandissimo successo, tanto che negli anni seguenti Harwood
fu costretto a chiudere la fabbrica che aveva avviato per la produzione
di tali orologi. |
|
Pochi anni dopo, ci fu un’altra
importante tappa nella storia dell’automatico. Hans Wilsdorf, (ovvero
Mr. Rolex ), applicò un dispositivo di carica automatica al suo già
famoso orologio impermeabile, assurto ai fasti della cronaca anche per
essere stato al polso della nuotatrice che attraversò per prima la
Manica. Nasceva così l’ Oyster Perpetual.
Il movimento Rolex presentava diverse novità rispetto a quello di
Harwood.
La massa oscillante era libera, cioè in grado di ruotare a 360°: il
risultato era una maggiore efficacia nella ricarica.
Il movimento si poteva caricare anche manualmente, attraverso la corona,
cosa non prevista da Harwood, che riteneva così di potere meglio
preservare l’orologio da infiltrazioni.
Il problema delle infiltrazioni però era superato nel movimento Rolex
con l’adozione della corona a vite.
.JPG)
|
|
Ma esaminiamo nel dettaglio il dispositivo automatico.
Qui possiamo osservare il movimento dopo che è stata levata la massa
oscillante.
.jpg)
|
|
In questa foto, dove è stata levata la
platina superiore del dispositivo di carica automatica, possiamo vedere
il treno demoltiplicatore, che consente la carica della molla anche con
piccoli spostamenti del rotore.
.jpg)
La massa oscillante è avvitata al suo albero (AM).
La ruota dentata (R)che ingrana con la prima ruota del treno
demoltiplicatore ha, nella parte inferiore, una corona di denti di sega,
sulla quale ingrana una molletta con piccole alette che lavorano proprio
su tali denti. La molletta ha un foro quadro, che praticamente la rende
solidale all’albero della massa oscillante.
Il cricco (C) che lavora sulla prima ruota del treno demoltiplicatore
permette la rotazione del tutto solo in un senso, impedendo lo
scaricamento della molla quando la massa oscillante gira nel senso
inverso a quello della carica.
Lo stesso principio viene ripetuto nella ruota (B) fissata all’albero
del bariletto. Anche qui viene interposta una molletta che, seppur più
grande, ha la stessa funzione della molletta sotto la massa oscillante.
La molletta lavora sul rocchetto del bariletto che ha una corona
superiore dentata a denti di sega come la ruota (R) .
In questo modo è possibile anche la carica manuale, poiché, quando
l’orologio viene caricato attraverso la corona, i cricchi della molletta
scivolano sui denti superiori del rocchetto, evitando rotture al
dispositivo di ricarica automatica.
Si intuisce quindi che l’automatico della Rolex carica solo in un senso
di rotazione della massa oscillante.
Nel movimento utilizzato per le foto invece lo scopo è raggiunto con una
serie di cricchi e ruote dentate che vengono letteralmente impilati
sull’albero del bariletto. Anche in questo caso comunque lo scopo è
quello di permettere la carica mediante la corona evitando qualsiasi
danneggiamento. |
|
Vediamo meglio il dettaglio dell’albero della massa
oscillante smontato e separato dalla ruota di trasmissione del moto.
Si può notare la molletta ad alette che lavora sui denti della ruota,
visibili perché la ruota è stata rovesciata.
A seconda del senso di rotazione della massa oscillante, la molletta
impegna i denti e fa avanzare la ruota, oppure scivola su di essi e fa
andare a vuoto la massa oscillante.
Si intuisce quindi che l’automatico della Rolex carica solo in un senso
di rotazione della massa oscillante.
.jpg)
|
|
Un’altra novità che troviamo
sull’automatico di Wilsdorf è la molla con il sistema di sicurezza, una
brida attaccata alla parte terminale della molla che permetteva lo
scivolamento della stessa quando la carica raggiungeva il valore
massimo.
Il problema di fondo di questo orologio però erano le sue dimensioni.
Wilsdorf applicò il suo sistema di ricarica su movimenti relativamente
piccoli, e questo, specialmente all’epoca, portava a non avere
prestazioni di alto livello per quanto riguardava la precisione.
In seguito apparvero anche diversi altri sistemi per la carica
dell’orologio, principalmente basati sulla trasmissione del movimento di
compressione e trazione del cinturino dell’orologio o del fondo della
cassa appoggiato al polso, ma non ebbero alcun successo, per la loro
scarsa affidabilità.
Questi sistemi alternativi furono ideati principalmente perchè Wilsdorf
brevettò il suo sistema ed altri dispositivi simili, di fatto impedendo,
finché tali brevetti non scadessero, di sviluppare in alcun modo i suoi
sistemi di carica automatica da parte di concorrenti. |
|
Un altro passo in avanti fu fatto
quando la Felsa, nel 1942 creò il Bidinator, il primo automatico che
permetteva la carica in entrambi i sensi di rotazione del rotore.
Il sistema era semplice.
La massa oscillante qui smontata, ed imperniata all’albero (A), era
solidale ad una ruota che ingranava con un’altra ruota (R) imperniata su
un braccio basculante (B).
Questa ruota a sua volta poteva ingranare con una delle due ruote
“invertitrici” (I1) o (I2) a seconda del senso di rotazione e far
caricare comunque sempre in un senso la molla attraverso la ruota (G)

|
|
La ruota (G), che nel disegno sotto è
rovesciata, nella parte inferiore era dotata di una molletta (M)
solidale al pignone che ingranava il rocchetto del bariletto. La
conformazione della molletta (rossa) permetteva il suo scivolamento
rispetto alla ruota (verde) quando l’orologio veniva caricato
manualmente, mentre impuntandosi nei fori della ruota stessa permetteva
il suo avanzamento, e quindi la carica della molla, quando la massa
oscillante ruotava.
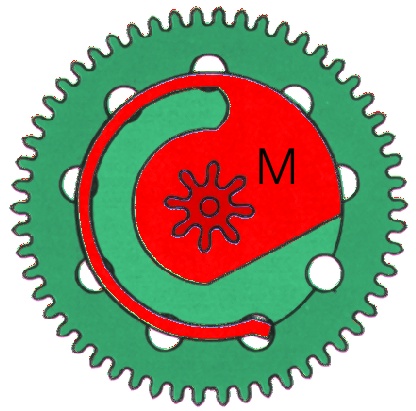
|
|
Un altro tra i sistemi da ricordare era quello con
massa oscillante a “martello” che si trova ancora su vecchi movimenti
automatici di varie marche, Omega per esempio.
Le molle respingenti poste a
fine corsa della massa oscillante avevano lo scopo di aumentare il
numero delle oscillazioni della massa stessa, caricando maggiormente la
molla, ma lo svantaggio della minore escursione e conseguentemente di
minor ricarica che queste molle portavano, non era compensato dal
maggior numero di oscillazioni.

|
|
Un altro cenno particolare merita il
sistema a doppio pignone, vediamo un esempio nel movimento Omega in
foto, dove il moto della massa oscillante veniva trasmesso ai ruotismi
da una coppia di piccole ruote, indicate dalla freccia, poste a loro
volta su un ponte imperniato alle platine che permetteva di trasmettere
il moto qualsiasi fosse il senso di rotazione della massa oscillante.

|
|
Un ulteriore sistema fu brevettato
dalla IWC, il Pellaton: il sistema prevedeva una camma a forma di
cuore, solidale alla massa oscillante, che faceva muovere due cricchetti
che a loro volta attraverso altre ruote caricavano la molla.

Il particolare del dispositivo:

In definitiva, dopo aver esaminato questi sistemi di
carica automatica possiamo giungere ad alcune conclusioni:
-il primo sistema di carica automatica, di Perrelet, è stato
completamente dimenticato e successivamente reinventato.
-Il suo principio in pratica è lo stesso che fa funzionare molti dei
movimenti automatici che sono in produzione.
-Altri marchi, o casa produttrici di movimenti, si sono orientati verso
il sistema a doppio pignone.
-Pochissimi hanno continuato la strada delle soluzioni alternative. (IWC
col Pellaton).
-Tutti hanno adottato il rotore con rotazione a 360°. |

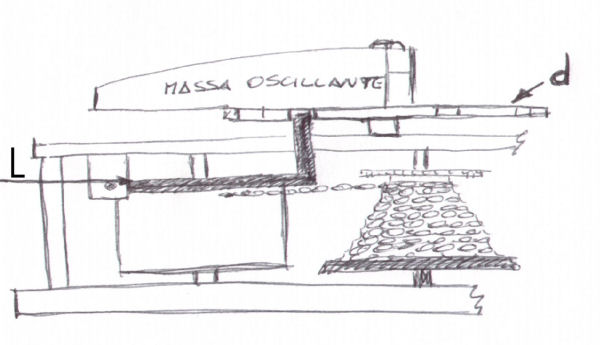



.jpg)
.jpg)
.jpg)